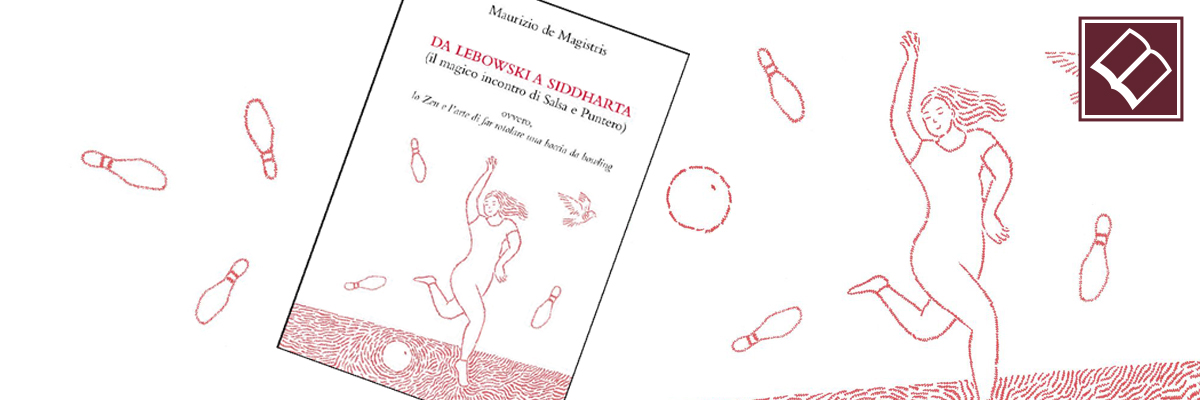Alterità, solitudine, coscienza universale e unione col mondo
(da La ferita dei non amati di Peter Schellenbaum)
Sperimentare l’alterità
(…)
Talvolta ho l’impressione che le persone che mi rivelano un segreto in quanto psicoterapeuta intendano in realtà qualcosa di diverso, uno stato di diversità che non può essere espresso a parole, qualcosa di primordialmente estraneo, un puro mistero che non è un enigma irrisolvibile. Questa alterità esistenziale, che non è completamente riducibile a un’espressione concreta cerca inutilmente esperienze e fatti che le consentano di esprimersi. Oggi chiunque può raccontare un episodio della sua vita credendo che contenga la chiave della sua storia esistenziale. Dopo qualche settimana la stessa persona racconterà un altro episodio che gli sembra rivelare un indizio decisivo. E via di seguito. Questi tentativi di spiegazione rimuovono l’aspetto esistenziale della solitudine o del non essere amati, che fa sentire di essere catapultati in un mondo alieno di essere nati troppo presto, di precipitare in abissi sconosciuti senza appoggi e senza sicurezza. La persona in questione vorrebbe aggirare questo senso di essere radicalmente ‘altro’ esponendo, uno dopo l’altro, i segreti del proprio intimo; in questo tradurre in parole ciò che è diventato afferrabile, essa sta cercando un sostegno. Ma proprio questa rinnovata ricerca di nuove spiegazioni dimostra che ciò che questa persona intende supera ogni possibilità di spiegazione.
(…)
Se riconosciamo e accettiamo la dimensione della nostra alterità, e quindi ammettiamo di non avere ogni cosa sotto controllo ma di sfuggire costantemente noi stessi, senza per questo essere schizoidi o persino psicotici, avviene in noi qualcosa di assolutamente notevole; ci uniamo al mondo e cominciamo ad amare. Un’incredibile, radicale liberazione ha luogo
quando smettiamo di nascondere la nostra condizione esistenziale di non amati e di insicurezza, la nostra fondamentale solitudine, e addirittura facciamo di tutto questo la forza propellente della nostra esistenza. Il paradosso è insuperabile. Ci consentiamo di cadere, dalle profondità del nostro essere, nella realtà di non essere amati, di essere perduti, senza il minimo grado di distacco quali osservatori, e per la prima volta siamo completamente uniti al mondo poiché siamo amante e amato in un’unica persona.
Un’unica solitudine
Questo paradosso è davvero così strano? L’alterità consapevole non corrisponde forse alla liberazione da una coscienza dell’Io che ci ha isolato dall’altro presente in noi, dal mondo e dal prossimo? La solitudine non è forse essenzialmente contatto con altri solitari, unione nel mistero di ciò che è inaccessibile, spontaneo e muto, piuttosto che in ciò che è conosciuto, nelle abitudini e nelle convenzioni di pensiero consolidate, in ciò che da lungo tempo è difeso e precisamente codificato? Tra due solitudini nasce l’amore, come una scintilla di un comprendersi senza capire, un’intensità di sentimenti senza sentimenti che possano essere spiegati, una liberazione senza un’iniziale modifica della situazione di vita. Questo amore scaturisce dall’intuizione che tutte le solitudini sono una, che esiste soltanto un’unica solitudine, un unico abisso comune, un unico ammutolirsi, un unico vuoto. L’insight nell’identità sottostante all’essere amati e non amati, al rapporto e alla solitudine, è l’evento che ci libera e ci rende umani.
L’alterità individuale, come per esempio l’appartenenza a una razza diversa, un handicap, un difetto, un interesse sessuale che contraddice la norma, il mancinismo, un talento straordinario o un vizio disprezzato, indica la fondamentale alterità di ogni essere umano. E importante identificarsi con la propria alterità individuale in modo da dedicare un’attenzione amorevole a questo particolare tesoro. Tuttavia, per evitare l’isolamento, è altrettanto importante saper vedere, dietro l’alterità individuale, l’alterità fondamentale, quella solitudine essenziale che condividiamo con ogni altro essere umano. L’evidente diversità di una data persona segnala la presenza di un’alterità ed estraneità esistenziali. Se potessimo entrare nei panni di un’altra persona, riscopriremmo questa alterità. Si tratta di una comprensione importante anche per la psicologia, in quanto essa tende a ignorare e superare i fatti esistenziali attraverso la terapia.
Un collega mi parlò di un travestito sposato che soffriva perché la moglie si rifiutava di guardarlo e ammirarlo quando indossava abiti femminili. Sentiva che la moglie non amava ciò che in lui era speciale, e che quindi lo isolava. Egli non avvertiva alcuna contraddizione tra la sua passione per gli abiti femminili, i gioielli, il trucco e l’amore per la moglie. Gradualmente imparò ad amare quell’aspetto della propria personalità che la moglie non amava. A questo punto, era importante che anche la moglie imparasse a riconoscere le proprie diversità e particolarità, a intensificare il senso di ciò che era unico nella sua personalità. Adesso, ciascuno dei due poteva rivolgersi a quegli aspetti interiori e fondamentali di sé che l’altro non amava e non capiva. Svilupparono così una sensibilità verso ciò che era radicalmente altro e strano nella generalità della gente, pur non esprimendolo concettualmente. La scoperta di questa nuova sensibilità rappresentò per entrambi un passo decisivo verso la maturazione, e il loro amore divenne più profondo e più intenso. Avevano perso l’illusione del totale accordo nell’amore e avevano scoperto che solitudine e amore sono reciprocamente dipendenti.
Nel suo scritto autobiografico Solo August Strindberg sottolinea un altro valore della solitudine. Il temporaneo rifugiarsi nella solitudine consente di dirigere l’energia verso quegli aspetti non sviluppati della personalità che rimarrebbero non vissuti se esposti a forte influenza esterna. Tessere un bozzolo con il filo di seta della propria anima, farsi crisalide e attendere la trasformazione rende possibile un nuovo orientamento basato sulle proprie risorse. Questo è un aspetto della solitudine che C.G.Jung fu il primo a investigare, chiamandolo «regressione progressiva», reculer pour mieux sauter, retrocedere di alcuni passi per saltare meglio. Nella profondità essenziale di ciò che siamo troviamo gli elementi per un nuovo inizio creativo.
E’ giunto il momento di chiederci come è possibile trasformare la solitudine in amore per l’altro. Rispondere in termini puramente intellettuali significherebbe ingannarsi. Solo descrivendo un’esperienza posso sperare che la scintilla raggiunga un’esperienza analoga nell’animo del lettore. Qual’è quindi la mia personale esperienza di solitudine? Che cosa accade in me se non rifuggo la solitudine come un qualcosa di negativo ma divento tutt’uno con essa, ne traggo energia e ne faccio un potenziale di sviluppo? La risposta a questo interrogativo può venirci dalla meditazione, intesa non come contemplazione o visualizzazione di immagini, ma nel senso del buddhismo, soprattutto Zen, come vigile non agire, lasciando consapevolmente che i processi corporei avvengano, specie il respiro nel suo andare e venire, in rilassata, benevola attenzione verso ciò che spontaneamente accade in noi, in una postura del corpo che stimoli questa attenzione: liberamente seduti sui talloni o a gambe incrociate, oppure nella posizione del semiloto, con la schiena diritta ma rilassata. Assorti in questa meditazione primordiale non sprofondiamo in noi stessi, ma ci sentiamo come una tigre pronta al balzo, come disse il Lama Sogyal Rimpoche: completamente rilassati eppure vigili, estremamente sensibili ai movimenti vitali del corpo e del mondo esterno. Nel respiro che va e viene, percepiamo la nostra potente, irremovibile volontà di vivere. Quasi, non possiamo fare altro che respirare. Uniamoci quindi alla respirazione che diviene un ritmo vitale profondamente appagante. Anche i suoni del mondo esterno, tutti i suoni, non soltanto quelli che consideriamo ‘belli’, sono vita direttamente vissuta: un bambino che urla, una madre che
chiama, un aeroplano, un colpo metallico, un’automobile che passa. Nella loro casuale successione, nel loro interagire, questi suoni così diversi formano una sinfonia che si impone da sé.
Durante questo tipo di meditazione accade qualcosa di ancora più notevole: i segnali di vita del proprio corpo e del mondo esterno diventano tutt’uno, non nel senso che confondiamo noi stessi e il mondo, come nella trance o nel sogno, in una sorta di fumoso miscuglio di esperienze. Questa rilassata attenzione verso tutto ciò che accade, senza l’intervento di inopportune riflessioni, fa sì che noi stessi e il mondo esterno ci fondiamo in un tutto onnicomprensivo, una totalità che percepiamo in un modo insieme preciso e sfumato, anche all’interno della vibrazione vitale delle sensazioni, in ogni costellazione che il momento produce. In ogni istante siamo consapevoli del tutto attraverso i singoli aspetti che stimolano i sensi.
La citazione seguente, tratta da Jung, in cui egli assimila la coscienza nel senso della filosofia indiana all’assenza di coscienza della psicologia del profondo, è applicabile soltanto alla trance degli yogi indu e non può essere estesa a tutte le forme di meditazione occidentali. Jung scrive:
Essi [gli yogil non si rendono conto che una ‘coscienza universale’ è una contraddizione in termini, in quanto l’esclusione, la scelta e la discriminazione costituiscono la radice e l’essenza di tutto ciò che può aspirare al nome di ‘coscienza’. Al contrario la ‘coscienza universale’ è, da un punto di vista logico, identica all’assenza di coscienza […1 Aumentando l’estensione, i contenuti della coscienza perdono di chiarezza nel dettaglio. Alla fine, la coscienza diviene comprensiva ma nebulosa; un numero infinito di cose si fonde in un tutto indefinito, uno stato in cui soggetto e oggetto sono quasi completamente identici. Tutto ciò è molto bello, ma poco consigliabile per aree situate a nord del Tropico del Cancro.
La coscienza universale
Molti yogi e molte persone che praticano lo Zen non sono d’accordo con il giudizio che Jung esprime sulla meditazione yoga. Per loro, la meditazione implica l’esperienza di una straordinaria liberazione rispetto al tutto mediante la percezione diretta e imparziale di singoli aspetti di ciò che accade al momento. La lontananza nebulosa dalla realtà, che per essi costituisce la coscienza normale, è superata. Nei momenti di aperta attenzione, cadono gli abituali veli della rimozione e dell’evitamento e affiora la chiaroveggenza mediale di coloro per i quali meditazione e vita attiva sono divenute tutt’uno. In breve tempo essi afferrano situazioni complesse che altri inseguono faticosamente e senza successo. Oltre al processo di lavoro introspettivo sulle rimozioni, i traumi possono effettivamente essere annullati attraverso una temporanea identificazione cosciente con ciò che sta accadendo grazie alla meditazione. Partendo dalla prospettiva di questo secondo tipo mediale di presa di coscienza di ciò che è stato rimosso, non cercheremo più di oggettivare l’inconscio e i suoi contenuti inconsci, ma parleremo soggettivamente di un atteggiamento di inconsapevolezza, che è l’opposto della chiarezza intellettuale che illumina la meditazione. Da circa una ventina d’anni, questa chiarezza intellettuale, in cui la consapévolezza dell’universale e dell’individuo sono la stessa cosa, è diventata un’esperienza quotidiana anche per un numero crescente di occidentali. Questa meditazione comporta una coscienza universale del rapporto, che comprende il singolo come processo relazionale all’interno del tutto e viceversa.
Già Erich Neumann, allievo di Jung, ha dimostrato che accanto alla coscienza riflessiva esiste una coscienza vigilmente ricettiva, che comprende il tutto in termini di ciò che si verifica nel momento. Neumann la chiama “coscienza matriarcale”.
Via via che la meditazione si fa più profonda, il mondo (se stessi e l’altro, ciò che è interiore e ciò che è esterno) diventa un’unica orchestra e un’unica sinfonia, dove il problema di distinguere tra assonanze e dissonanze, tra armonia e disarmonia non si pone più. La grande affermazione a tutto ciò che esiste è anche affermazione alla negazione: a tutti i poli negativi presenti nel gioco delle energie, alla caducità e alla morte. La rabbia distruttiva separata dalla vita si fonde in questa grande affermazione e si trasforma sempre più nella capacità di essere attivi e di cogliere le opportunità che la vita offre.
Così, nella meditazione emerge che solitudine e amore per l’altro sono identici. Nell’abbandonare ciò che è mio e ciò che è tuo, scopriamo che “la sostanza dell’universo non può strapparsi” (Pierre Teilhard de Chardin); che stare bene con se stessi significa al tempo stesso essere nel mondo o, meglio ancora, essere il mondo; che il corpo con i suoi organi di senso, così come il resto del mondo, sono rapporti, legami ed energia pulsante; che esiste un unico amore indiviso, cioè l’amore per tutto ciò che esiste; e che, infine, l’amore non è altro che questo vigile, ardente essere nel rapporto, che crea unione. Nei momenti di silenzio interiore l’uomo riconosce l’illusoria natura dei pensieri che lo separano dalla vera vita, dall’amore.
La meditazione non finisce dopo i venti trenta minuti di seduta ma diviene un modo comprensivo di percepire e di amare che ogni volta richiamiamo con più precisione alla mente durante una meditazione speciale, che implica il lasciar accadere, il non opporsi, non separarsi e il consapevole rilassamento, come ho evidenziato parlando del massaggio mentale, che è anche una forma di meditazione. E’ il modo di essere che aiuta il nostro mondo ad andare avanti.
Gli sviluppi del mondo moderno ci hanno portati a un punto dove gli aspetti più esterni (la politica) e quelli più interiori (la meditazione) parlano la stessa lingua. Entrambi condividono il principio fondamentale secondo cui solo la ‘distensione’ può aiutarci ad andare avanti. Ogni segreto è racchiuso nell’arte del lasciarsi andare, del non oppone resistenza […] In ultima analisi, oggi la grande politica è meditazione sulla bomba, e la meditazione profonda cerca in noi l’impulso esplosivo [..] Resta una sola domanda da porsi: se scegliere il cammino esteriore o quello interiore; se la comprensione verrà dalla coscienza o dalle palle di fuoco sulla terra (P.Sloterdijk).
Cosi, la distensione scaturirà da un tornare in se interiore o da una catastrofe esterna? La via interiore alla distensione è l’amore per ogni essere vivente, quella esterna la distruzione di ogni cosa.
Ciò che serve è un fondamentale atteggiamento di compostezza intesa nel senso di Buddha e di Heidegger. La compostezza significa rinunciare a ciò che vuole la mia volontà isolata e accettare ciò che ora vuole accadere, essere disponibile, lasciarmi coinvolgere dal reale e perseguirlo. A questo proposito, Meister Eckhart parla di non-conoscenza, non-possesso, non-volontà. Una psicologia che segua il soggetto umano in tutto e non trasmetta le limitazioni del proprio metodo, sfocia nella mistica. L’antica saggezza insegna che la ‘sottomissione’, nel senso di questa compostezza, e la più vigile delle attività non si escludono, ma si condizionano reciprocamente. L’insegnamento di Krishna ad Arjuna nel BhagaVadgita, l’elemento centrale del Mabaharata, poema epico indiano e ‘vangelo’ degli indu, raggiunge in ciò il suo apice. L’adattamento del Mahabarata a cura di Jean-Claude Carrière e la sua messa in scena a cura di Peter Brook hanno trasformato questo messaggio in un evento direttamente accessibile anche agli spettatori occidentali. Nei cantieri navali di Zurigo, dove l’opera è stata rappresentata, predominava un umore allegro, una rilassata vitalità, una stimolante compostezza, un caloroso legame tra attori e spettatori, come non avevo mai visto. La rappresentazione era stata una meditazione collettiva e condivisa.
“Dimentica il desiderio”, in altre parole, quella volontà isolata che non è in sintonia con la situazione generale, e “cerca il distacco” è l’esortazione di Krishna ad Arjuna. Con ciò, egli intende dire che Arjuna deve prescindere dalle motivazioni egoistiche e gettarsi nell’inevitabile battaglia con i suoi parenti: sottomettersi alla necessaria attività. In questa situazione, l’atteggiamento decisivo è la compostezza. Krishna chiede ad Arjuna: «Puoi combattere senza ira e senza orgoglio?», ossia: puoi combattere compostamente?
In unione con il mondo
Il vero solitario rinuncia ad aggrapparsi agli uomini, alle abitudini mentali e ai sentimenti comunemente condivisi, alle ideologie e alle religioni, o a cercare un appoggio, qualunque esso sia. In questa rinuncia, egli si libera dall’illusione di un mondo che sembra essere separato e capace di provvedere quelle cose di cui egli stesso manca. Il vero solitario è così intimamente
e interiormente legato al mondo che esso non può più offrirgli alcun sostegno o supporto, poiché egli è tutt’uno con l’unione al mondo, al mondo come rapporto, al ‘soggetto universalmènte fluido’. Sia ben inteso: egli non inflaziona la propria soggettività fino ai confini del mondo, ma la sua soggettività si fonde nella convinzione che l’identità, come dice M. Buber, è nel mezzo, nel rapporto.
È magnifico essere solo se quell’uno in cui vivo la mia solitudine è il mondo.